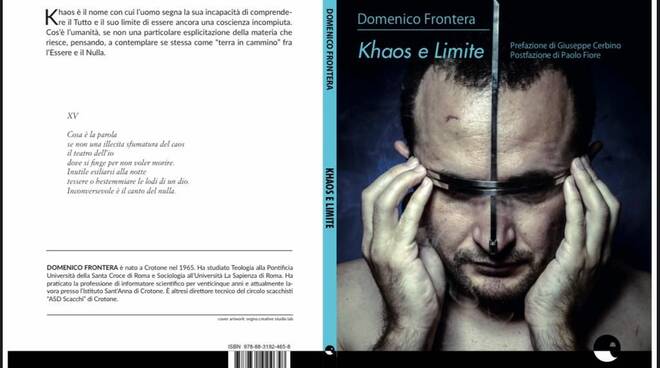Il viaggio di Dudu Berdjie
LE STORIE ESCLUSIVE DI COSENZAINFORMA.IT. Intervista ad un giovane del Gambia ospitato a Camigliatello assieme ad altri 120 migranti
Più informazioni su

“We are just alive. Nothing else.”
Domenica 4 dicembre la Sila era perfetta. Uggiosa, piena di colori autunnali, freddissima. Ho fatto un giro solitario, e ho incontrato uno di loro in contrada Forgitelle. Camminava con le mani in tasca e gli auricolari, da solo. Gli ho chiesto se gli andasse di fare un’intervista, ed alla sua risposta entusiastica ho immediatamente contrapposto un prudente “non sono un giornalista”, aggiungendo che avrei comunque voluto fare due chiacchiere che poi avrei pubblicato, se fosse stato d’accordo. Dudu mi ha risposto con un grande sorriso che sì, ci saremmo incontrati dopo un’ora, perché doveva raggiungere alcuni amici bulgari con cui avrebbe pranzato. Ho provato un vago senso di tenerezza immaginando quella tavolata. Era da qualche giorno che avevo in mente di parlare con qualcuna di quelle persone. Più o meno da quando è iniziato il freddo.
Quando ci siamo rivisti ci siamo presentati meglio: Dudu ha 23 anni e viene da Serrekunda, in Gambia. È arrivato il 30 giugno in Italia, salvato da una nave olandese appena 5 ore dopo essere salpato da Tripoli. Ora vive in Sila, a Camigliatello, insieme ad altri 120 migranti. Quando, durante il corso dell’intervista, ha pronunciato i nomi di alcune località, gli ho chiesto di scriverli sul bloc-notes comprato appositamente poco prima dell’intervista, perché non li capivo.
Cerco su Google Earth il nome esatto di quei luoghi, mentre scrivo. Voglio avere un’idea del viaggio del mio amico.
Serrekunda è la città più grande del Gambia, anche se non ne è la capitale. Capita spesso, in Africa. Di solito questo corrisponde all’esigenza tutta occidentale di spostare i centri amministrativi e finanziari al riparo dalle metropoli ritenute poco sicure.
-Perché hai lasciato il tuo paese, Dudu?-
-Perché non ne potevo più di vivere in casa con il mio patrigno.-
Una motivazione piuttosto originale per lasciare il proprio paese e rischiare la vita, ho pensato.
-E tua madre, i tuoi fratelli?-
-Mia madre è morta, non ho fratelli. Era la terza moglie di Ibrahim, che aveva altri figli con le altre due mogli. Negli ultimi tempi, qualunque cosa accadesse in casa o nei paraggi di casa, il mio patrigno me ne dava la colpa.-
-Cosa facevi in Gambia?-
-Lavoravo in una fabbrica d’infissi, sono bravo a lavorare l’alluminio e il vetro.-
-E poi? Cos’è successo?-
-Un po’ più di due anni fa (febbraio 2014, ndc) ho lasciato il Gambia con il mio amico Talibe per andare a Nord, in Mauritania, nella capitale Nouakchott. Mi avevano detto che c’era molto lavoro. Un lungo viaggio in autobus, attraverso il Senegal, per restare lì un anno.-
-Perché solo un anno? Perché sei andato via dalla Mauritania? Non ti trovavi bene?
-Mi trovavo bene, avevo un lavoro e qualche buon amico. Ma non avevo il permesso di soggiorno. Un giorno il taxi (furgoncini strapieni di passeggeri, ben oltre i nove posti previsti, ndr) su cui viaggiavo è stato fermato dalla polizia. Quando hanno scoperto che né io né Talibe avevamo il permesso di soggiorno, ci hanno detto che ci avrebbero espulso dal paese. Così abbiamo cominciato a correre, ma loro avevano le moto. Dopo qualche centinaio di metri ci hanno raggiunto e portato in una caserma, dove ci hanno picchiato selvaggiamente e hanno preso tutti i soldi che avevamo. Il giorno dopo ci hanno accompagnato alla stazione e ci hanno messo su un autobus per il Mali. In Mali abbiamo dormito per tre giorni nella stazione degli autobus, nella città di Gory, appena oltre il confine con la Mauritania. Avevo freddo, pioveva sempre. Il 4° giorno davanti alla stazione si è fermato un camion. Alla guida c’era un uomo dai modi molto gentili che ci ha chiesto dove fossimo diretti. “Ovunque, lontano da qui”. “Vi consiglio l’Algeria”, ha risposto. “Posso darvi un passaggio.” In realtà era un ribelle, che ci ha portato in un posto, in mezzo al deserto, in cui c’erano alcune baracche dove abbiamo trovato alcuni suoi amici. Uno di questi ci ha accolti in francese, ma noi non capivamo (il Gambia è una stretta lingua di terra all’interno del Senegal, praticamente un’enclave in cui si parla inglese all’interno di un’immensa area francofona, ndr.). Poi ha sventolato delle banconote e un fucile, minacciandoci di morte se non avessimo pagato un riscatto. Gli ho detto che non ero un immigrato che lascia una famiglia capace di trovare un po’ di soldi per salvarlo. Ero una specie di rifugiato, come sono adesso. Il mio patrigno non avrebbe mai pagato un centesimo per me. I miei ultimi soldi ce li avevano i poliziotti di Nouakchott. Dopo tre giorni lo stesso uomo che ci aveva minacciato si è messo a urlare con l’autista del camion, che ci ha fatto risalire per poi abbandonarci in un altro posto in mezzo al deserto.
– Qui Dudu si è fermato un po’. Si è commosso. Ho cercato di distrarlo. Ci prendiamo un caffè? Un tè? Un succo di frutta?. Mi aspettavo una risposta entusiasta. No. Queste cose non gli mancano, qui. Hanno da mangiare e da bere. Gli manca altro, evidentemente.
-Quanto tempo siete rimasti nel deserto? –
Tre giorni. Senza cibo né acqua. Per dissetarci abbiamo bevuto urina di cammello.-
Nel corso dell’intervista ho dubitato più di una volta della veridicità delle cose che Dudu mi ha raccontato. Tre i giorni di prigionia nelle mani dei ribelli, tre i giorni trascorsi nella stazione degli autobus in Mali, tre quelli nel deserto. All’inizio dell’intervista ho perfino sentito la parola “daughter”, “figlia”, in mezzo a molte altre che non ho compreso. Ho pensato che se mi nascondeva qualcosa era per il più democratico di tutti i sentimenti: la paura.
-E poi cosa è successo, Dudu?-
-Sono arrivati i Tuareg.-
Siamo stati interrotti dall’arrivo di un ragazzo bianco, magrissimo e molto alto. Dai tratti mediorientali, sui 20 anni. Indossava una t-shirt e una felpa di cotone troppo leggere per la Sila. Come Dudu, che però sopra aveva un giubbotto di pelle. -Good evening- ci ha salutato timidamente il ragazzo.
-Lui è Muhammad, un mio amico. È pakistano, condividiamo la stanza. “Good afternoon”, Muhammad. “Evening” si dice più tardi.-
lo ha corretto con fare da fratello maggiore Dudu.
Ho offerto da bere e da mangiare anche a Muhammad, a cui poi ho chiesto di scrivermi il suo nome per intero, che provo qui a trascrivere: Ikram-Ul-Haq-Muhammad. Anche lui, come Dudu, ha rifiutato gentilmente. Sono sembrati così appagati dall’emozione di parlare con qualcuno che potesse raccontare la loro storia. Forse è questo ciò di cui hanno bisogno: qualcuno che racconti la loro storia, qualcun altro sappia che è vera, qualcuno sappia che esistono.
-Mi stavi parlando dei Tuareg.-
-Sono arrivati sui cammelli, erano in cinque. Ci hanno dato da bere e da mangiare. Ci hanno portato a dorso di cammello per qualche ora. Siamo arrivati in un villaggio e abbiamo passato la notte lì. Non volevo scappare, ero vicino al fuoco ed ero stanco. La mattina dopo ci hanno spiegato, in inglese, che ci avrebbero venduti, come si fa con il bestiame o con un credito, ad alcuni algerini che sarebbero passati a prenderci nel pomeriggio. Speravo che il buio non arrivasse mai. Gli algerini sono arrivati a bordo di un camion. Ci hanno fatti salire a bordo e ci hanno trattato bene. Dopo due giorni di viaggio in cui abbiamo dormito nel rimorchio del camion siamo arrivati a Tamanrasset, in Algeria. Siamo stati venduti, non so per quanto, a una famiglia maliana. Appena entrati in casa, ci hanno dato un telefono dicendo di chiamare a casa per avere un riscatto.-
-Ancora riscatti. E voi senza un centesimo. Ho capito bene?-
-Sì. Ci hanno minacciati di frustarci se non avessimo dato loro dei soldi. Quando abbiamo convinto quella gente che non ne avevamo, ci hanno risposto che avremmo lavorato per pagare. Ho avuto paura che ci facessero lavorare per loro, ma il giorno dopo ci hanno affidato a un uomo che fabbricava mattoni. Ci ha trattato bene. Non ci pagava, ma ci dava da dormire e da mangiare. Tutto nella fabbrica di mattoni.-
-Quanto tempo vi siete fermati in quella fabbrica?-
-Un mese, più o meno.-
-Poi dove siete andati?-
-Quell’uomo ci ha detto di andarcene. Non aveva più bisogno di noi. Ci ha detto: “Andate a Ouargla, da lì riuscirete ad arrivare in Libia e poi in Europa.” Ci ha dato un po’ di soldi per i biglietti. Era un uomo buono. Con quei soldi siamo andati alla stazione degli autobus, dove però il mio amico Talibe si è tirato indietro. Quando mi ha salutato mi ha detto che si sarebbe fermato a Ain Salah e da lì avrebbe tentato di andare in Marocco. Siamo partiti alle 6 del mattino da Tamanrasset, e dopo sei o sette ore di viaggio lui è sceso alla sua fermata. Appena la porta del bus si è chiusa e l’ho visto camminare dandomi le spalle mi sono messo a urlare, pregando l’autista di farmi scendere. Ho raggiunto Talibe e siamo stati altri due giorni insieme. Poi sono ripartito per Ouargla. Adesso ero completamente solo.-
-Quanto tempo ti sei fermato a Ouargla?-
-Quattro mesi. Nel campo profughi di Citymali, più di 7000 persone in pieno deserto. Sono stati quattro mesi duri. Mai avuto tanto caldo. Devo aver avuto anche qualche malattia, ma non so quale.-
-Poi?-
-La notte del 28 novembre (del 24, dalle verifiche effettuate, ndc.) un grosso incendio ha devastato il campo. Sono morte molte persone. Anche bambini. Dopo due giorni in cui abbiamo dormito per terra, senza ombra di giorno e senza coperte di notte, ci hanno trasferito in una prigione abbandonata. Sono rimasto lì per circa 6 mesi, poi sono scappato, di notte, verso la Libia. Seguendo le strade e le luci dei pozzi di petrolio sono arrivato a piedi a Deb Deb, a poche centinaia di metri dal confine con la Libia.-
Avevo io, adesso, il bisogno di fermarmi. Di tutto il racconto, l’idea di un ragazzo solo, di notte, in mezzo al deserto algerino, con la sola luce degli impianti petroliferi e delle fiammate dei pozzi mi ha turbato più di tutte le altre immagini. Se mi chiedessero un’istantanea dell’apocalisse penserei a questa. La modernità indifferente ai drammi consumati a pochi metri dalle sue reti metalliche, illuminati per sbaglio dalle sue fotoelettriche. La contrapposizione dell’istinto primordiale del muoversi, dello spostarsi da un luogo all’altro, alla potenza sorda del progresso tecnologico. Ho chiesto a Dudu e Muhammad il tempo di un caffè. Mentre lo bevevo correggevo le parole scritte male, in fretta, sui miei appunti. Ero certo che mi avrebbe raccontato che una volta in Libia era stato arrestato di nuovo. Ormai mi ero abituato a quelle scene. Poliziotti con divise tutte uguali -a prescindere dal paese-, con macchine più o meno nuove e potenti –in funzione del paese- abituati ad arrestare qualunque straniero africano. Questo non mi avrebbe meravigliato.
-La Libia, finalmente.- L’ho anticipato.
-Di notte, lontano dalla strada principale, ho attraversato il confine e mi sono diretto a piedi verso nord, verso Tripoli. Il mattino seguente un’auto della polizia mi ha fermato per la strada, chiedendomi i documenti e come fossi entrato nel paese. “I miei documenti sono andati perduti nell’incendio del campo profughi”, ho detto loro la verità. E così mi hanno arrestato e portato a Ghadames. Dopo una settimana mi hanno lasciato andare. Ho fatto l’autostop e dopo un giorno di viaggio sono arrivato a Tripoli. A Tripoli è facile diventare un’ombra. Sembra che tutto il mondo passi ogni giorno da lì. Ho trovato lavoro in un bar, in periferia. Pulivo il pavimento, più volte al giorno, in cambio di cibo e un letto. E pochi soldi. A giugno di quest’anno ho racimolato abbastanza per prendere una barca fino a Lampedusa. Una mattina, molto presto, siamo partiti da una spiaggia a ovest di Tripoli, Sabratah, e dopo poche ore eravamo già alla deriva. Il motore si era spento. Di quelle ore mi ricordo solo l’odore di urina e di benzina. Non si vedeva la terra ferma. Da nessuna parte. Sembrava che la barca si muovesse, ma forse girava su se stessa. Dopo qualche ora siamo stati salvati da una nave di soccorso olandese, che ci ha portato a Lampedusa.
– Si è commosso di nuovo, Dudu. “No land”, diceva. Mi ha detto che quando ha visto Lampedusa, una volta diradatasi la foschia del mattino, ha avuto la sensazione di rivedere un vecchio amico.
Pensavo che il racconto finisse lì. E più o meno è andata così. Dudu si è fermato 25 giorni a Lampedusa e 8 ad Agrigento. Poi è stato portato in Calabria, in Sila, dove vive ora.
Fa solo questo, vivere.
“We are just alive. Nothing else.”, “nessuno viene a chiedere di noi, a vedere cosa facciamo, come stiamo”, sono state le ultime parole che mi ha detto Muhammad, dopo essersi confuso tra “afternoon” e “evening”.
Dudu ha annuito fissando un punto lontano.
Guardando la cartina, con i luoghi che ha percorso nel suo cammino lungo due anni, sette paesi e seimila chilometri, e unendoli con un tratto come si fa sulla settimana enigmistica, viene fuori una grande S, come Scappare. Quei nomi, scritti a penna da Dudu sul mio bloc-notes, li serberò con cura. Così mi ricorderò di lui e della sua storia che, almeno per un pezzo, non dovrà scriversi da solo.
Marco Scarpelli